Mi chiamo Lucy Barton di Elizabeth Strout sono appena 190 pagine nell’edizione originale, circa 150 in quella italiana. Sembra un libro smilzo finché non provi a raccontarlo. Allora ti accorgi di quanto sia denso e stratificato: cominci a dire una cosa e subito devi aprire una parentesi per aggiungerne un’altra, e poi un’altra e un’altra ancora. Mentre parli, ti vengono in mente altre cose che non avevi notato durante la lettura, e quando più o meno finisci, ti sembra di aver raccontato un romanzo di 500 pagine. Invece sono sempre 190, divise in capitoli brevi, con tanti paragrafi e a capo.
“C’era un tempo, molti anni fa, in cui dovetti restare in ospedale per quasi nove settimane.”
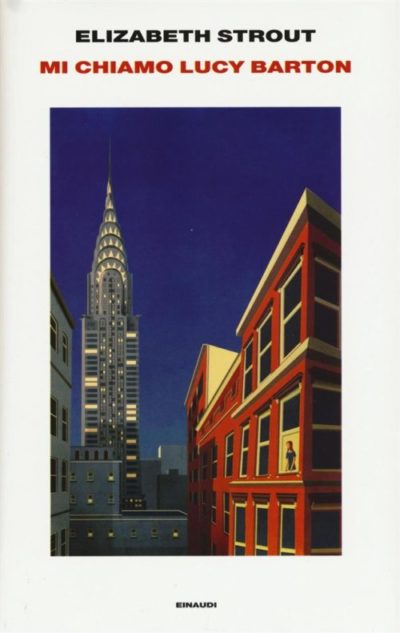 Lucy Barton ha subito un’appendicectomia, ma il suo ricovero si protrae per un malessere che i medici continuano a indagare senza riuscire a individuarne la causa. Dopo tre settimane, inaspettatamente va a trovarla la madre che Lucy non vede da molti anni. La donna si ferma con lei per cinque giorni, che sono il cuore del racconto. Cinque giorni in cui non dorme mai, si appisola sulla sedia, e tiene compagnia alla figlia raccontandole storie su vicini di casa e parenti, pettegolezzi, piccole chiacchiere, aneddoti: “Era il suono della voce di mia madre che volevo di più; quello che diceva non importava”. Madre e figlia non parlano mai, se non di striscio, della loro famiglia. Nel corso del racconto, fatto da Lucy a distanza di anni, quando è diventata una scrittrice apprezzata e benestante, apprendiamo che da bambina ha subito violenze fisiche e psicologiche, ha sofferto fame e freddo, vivendo isolata ai margini della società.
Lucy Barton ha subito un’appendicectomia, ma il suo ricovero si protrae per un malessere che i medici continuano a indagare senza riuscire a individuarne la causa. Dopo tre settimane, inaspettatamente va a trovarla la madre che Lucy non vede da molti anni. La donna si ferma con lei per cinque giorni, che sono il cuore del racconto. Cinque giorni in cui non dorme mai, si appisola sulla sedia, e tiene compagnia alla figlia raccontandole storie su vicini di casa e parenti, pettegolezzi, piccole chiacchiere, aneddoti: “Era il suono della voce di mia madre che volevo di più; quello che diceva non importava”. Madre e figlia non parlano mai, se non di striscio, della loro famiglia. Nel corso del racconto, fatto da Lucy a distanza di anni, quando è diventata una scrittrice apprezzata e benestante, apprendiamo che da bambina ha subito violenze fisiche e psicologiche, ha sofferto fame e freddo, vivendo isolata ai margini della società.
“Lucy viene dal nulla”, dice di lei la suocera. Dal nulla del midwest americano, della sua famiglia di miseri braccianti di un paesino rurale dell’Illinois, anche se quando Lucy dice alla madre che sono trash come Elvis, il povero ragazzo di Tupelo che voleva bene alla sua mamma, lei la rimprovera: “I miei antenati e quelli di tuo padre furono tra i primi ad arrivare in questo paese, Lucy Barton. Sbarcarono a Provincetown, Massachussetts, erano pescatori e colonizzatori. Abbiamo fondato questo paese.”
Il nulla da cui viene Lucy è anche il vuoto culturale che lei colma voracemente divorando libri fermandosi a scuola dopo le lezioni. La scuola è il ventre caldo che la accoglie e la nutre, opposta alla casa gelida e senza cibo. Cresciuta però senza televisione, rimane tagliata fuori dalla cultura pop e anche da adulta le mancano riferimenti comuni, spesso non sa di che cosa gli altri parlano. Anche quando è sposata e madre di due figlie, Lucy è sola:
“L’epidemia di AIDS era nuova. Gli uomini camminavano per strada, ossuti e smunti, e capivi che erano malati di questa peste improvvisa, dalle caratteristiche quasi bibliche. Un giorno, seduta sui gradini con Jeremy, dissi una cosa che mi sorprese. Dopo che due uomini così erano appena passati, dissi: ‘Lo so che è una cosa terribile da dire, ma sono quasi gelosa di loro. Perché loro si hanno a vicenda, sono legati in una comunità vera’. Lui mi guardò con un’espressione di sincera gentilezza sul viso. Adesso capisco che aveva capito quello che io non sapevo: che nonostante la mia pienezza, ero sola. La solitudine è stato il primo sapore che ho assaggiato nella vita, ed era sempre là, nascosto nelle screpolature della mia bocca, a ricordarmelo”.

Tra madre e figlia avviene un riavvicinamento nell’unico modo possibile: attraverso parole semplici, come semplice è la voce narrante del libro. La madre – intrisa di puritanesimo – non riesce nemmeno a dirle “ti voglio bene”, eppure Lucy si sente finalmente amata, coccolata. La madre rinomina il mondo maschile dei fondatori di cui fa orgogliosamente parte, inventando soprannomi per tutti, dai vicini di casa alle infermiere dell’ospedale; chiama anche la figlia con il nome del padre (quando la rimprovera) ma per il resto usa il vezzeggiativo e ciò basta a renderla felice. Era la madre che quando lavorava in una biblioteca portava a casa i libri che fanno conoscere la realtà e insegnano come comportarsi nel mondo:
“C’è la questione di come i bambini diventano consapevoli di che cos’è il mondo e come comportarsi in esso. Per esempio, come si impara che è maleducato chiedere a una coppia perché non hanno bambini? Come si apparecchia la tavola? (…) Come sai perfino che aspetto hai se l’unico specchio di casa è piccolo e sta in alto sopra il lavello in cucina, o se nessun’anima viva ti ha mai detto che sei carina, e invece, quando comincia a crescerti il seno, tua madre ti dice che inizi a sembrare come una delle mucche nella stalla dei Pedersons?”
Il padre di Lucy ha commesso un crimine durante la guerra in Europa. Per un crudele scherzo del destino, quel trauma riemerge attraverso la figlia ed è un altro fattore di isolamento dalla famiglia Non c’è complicità neanche tra Lucy e la sorella, ma la stessa diffidenza con cui si rivolgono al mondo. Lucy è diversa dai fratelli, si è emancipata attraverso i libri, che da bambina la facevano sentire meno sola e che lei ha iniziato a scrivere per non far sentire soli gli altri. Ha rinnegato le sue radici e le sue origini (trash, settlers, oddities, non importa). Tutto ciò accresce la sua estraneità e solitudine ma è l’unico modo per rifondare se stessa. Adesso che la sua vita è cambiata totalmente, Lucy pensa che forse, dopotutto, le cose non erano così terribili. Eppure “ci sono volte, inaspettatamente, mentre cammino lungo un marciapiede assolato, oppure osservo la cima di un albero piegarsi al vento, o il cielo di novembre chiudersi sopra l’East River, in cui all’improvviso mi sento riempire dalla consapevolezza di un’oscurità talmente profonda che potrebbe scapparmi un suono dalla bocca, allora entro nel primo negozio di abbigliamento e parlo con uno sconosciuto dei modelli dei nuovi pullover appena arrivati.”
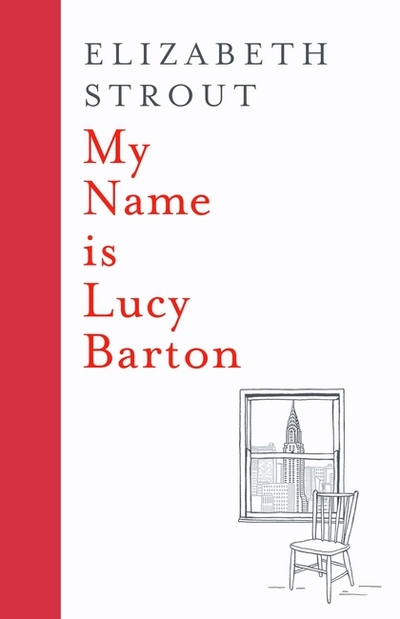 Subito dopo, nelle primissime pagine del romanzo, Elizabeth Strout riassume in sei righe il senso della vita, servendolo con la semplicità di una fetta di pane e burro di arachidi:
Subito dopo, nelle primissime pagine del romanzo, Elizabeth Strout riassume in sei righe il senso della vita, servendolo con la semplicità di una fetta di pane e burro di arachidi:
“Deve essere così che la maggior parte di noi manovra nel mondo, un po’ sapendo, un po’ no, colpiti da ricordi che non possono assolutamente essere veri. Ma quando vedo gli altri camminare sicuri lungo il marciapiede, come se fossero completamente liberi dal terrore, mi rendo conto di non sapere come sono gli altri. Gran parte della vita sembra solo congetture.”
In 190 esili pagine, Elizabeth Strout abbraccia cinque secoli di storia americana: l’arrivo dei coloni, la fondazione del paese, il genocidio dei nativi americani, la seconda guerra mondiale, la guerra del Vietnam, l’epidemia di AIDS degli anni ‘80-’90 e l’11 settembre. Tutto sembra appena nominato, come sfiorato in superficie, ma ogni elemento della narrazione – personaggio, fatto, considerazione o evento storico – si inserisce in profondità nella struttura del romanzo e altrettanto profondamente penetra nella coscienza del lettore, come porifere disidratate che assorbono e filtrano il liquido opaco della nostra psiche. Come un’eco che viaggia al contrario – un rimbombo che da lontano si fa vicino – per illuminare la nostra coscienza di individui e di esseri umani.
Mi chiamo Lucy Barton è un libro sul rapporto e l’amore tra madre e figlia, ma anche su come ci si separa, continuando ad amarla, dalla madre, e si diventa adulti. E’ un libro sulla vita che ci supera sempre e su come si impara, a fatica e con dolore, ad accettarla, con gli strumenti che a mani nude riusciamo a creare per noi. Per Lucy quello strumento sono le parole, che alla fine sono solo quattro, pronunciate con voce pura e generosa, semplici e immense nel loro sincero stupore.




Leave a Reply